Pubblicazioni 2025
Libri dei docenti di Italianistica pubblicati nel 2025

Vincenzo Vitale
Il Novellino di Masuccio Guardati
Storia, filologia e interpretazione di un classico del Quattrocento
Il Novellino è una raccolta organica di cinquanta novelle composte tra gli anni Cinquanta e Settanta del Quattrocento. L’opera, frutto dei legami di Masuccio Guardati con la corte aragonese di Napoli e con il vivace ambiente culturale e sociale della sua città natale, Salerno, si distingue per l’originalità tematica, stilistica e linguistica. Nonostante la censura ecclesiastica e i pregiudizi storiografici che ne hanno a lungo oscurato il valore, il Novellino ha esercitato un’influenza duratura sulla letteratura italiana ed europea dei secoli successivi. I saggi raccolti nel volume offrono un ampio ventaglio di prospettive: si va dalle questioni filologiche, linguistiche e stilistiche all’analisi dei modelli letterari, fino a letture di taglio interpretativo. Completano il quadro contributi sulla ricezione italiana ed europea e due interventi a carattere interdisciplinare.

A cura di Francesco Davoli
Rime (1529)
Le rime di Giovan Giorgio Trissino conoscono un’ampia diffusione manoscritta nei primi decenni del Cinquecento, accanto a quelle di autori di primissimo piano come Iacopo Sannazaro o Pietro Bembo. Nella princeps delle Rime del 1529 convergono quindi testi frutto di un’attività poetica distribuita su un esteso arco cronologico, dalla «prima giωvineza» alla soglia dei cinquant’anni. L’esito è una raccolta in cui affiora un lucido progetto di classicismo: sebbene a Petrarca venga riservato un ruolo prioritario fra i modelli, infatti, le Rime attingono abbondantemente sia dalla tradizione greca e latina sia da quella volgare due-trecentesca.
Il volume offre il testo della princeps delle Rime, rivisto e corretto, specie per quanto riguarda l’impiego del sistema ortografico trissiniano, alla luce dei principi di filologia dei testi a stampa e sulla scorta delle indicazioni che si ricavano dall’usus del vicentino o da sue esplicite indicazioni. Il testo critico è corredato di un commento puntuale che, per la prima volta, rende conto del mosaico di citazioni, di riprese e di libere traduzioni da svariati componimenti (greci, latini e volgari) di cui è innervata la produzione lirica di Trissino.

Maria Antonietta Terzoli (dir.)
Margini. Giornale della dedica e altro 19, 2025
Collegato all'Archivio informatico della dedica italiana, "Margini. Giornale della dedica e altro" vuole essere un giornale di scambio intellettuale e di riflessione teorica e storica su un argomento che negli ultimi anni ha incontrato un crescente interesse nel mondo scientifico: le dediche e altre parti dell'opera che, operativamente e adottando una terminologia ormai in uso, possiamo chiamare paratesti. O anche, con formula solo in apparenza analoga, "margini del libro". Diretto da Maria Antonietta Terzoli, prevede un comitato scientifico internazionale: Helmut Meter (Universität Klagenfurt), Salvatore Nigro (IULM, Milano), Klaus Opwis (Universität Basel), Marco Paoli (Biblioteca Statale di Lucca), Giuseppe Ricuperati (Università di Torino), Sebastian Schütze (Universität Wien). Ne è previsto un numero all'anno, con dimensione variabile secondo la disponibilità dei contributi. Flessibile e funzionale alla ricerca, "Margini" si compone di tre sezioni, Saggi, Biblioteca, Wunderkammer: la prima comprende studi inediti su dediche e marginalia di varia natura, la seconda propone in facsimile digitale articoli classici sull'argomento, la terza ospita trattatistica antica, antologie e raccolte di dediche, voci di dizionario, testi narrativi, iconografia e curiosità legate al tema. Elemento di coesione del giornale non è un'affinità metodologica o disciplinare, né una comune collocazione cronologica o geografica degli oggetti studiati, bensì una ricerca - anche molto differenziata nei metodi - su oggetti funzionalmente affini, benché tipologicamente dissimili e lontani nel tempo e nello spazio. Studiando il modificarsi di forme, strategie e funzioni di questo genere di testi, "Margini" ambisce a indagare il ruolo dello scrittore attraverso i secoli e le culture, ma anche ad analizzare la complessa, e spesso sofisticata interazione che si stabilisce tra le diverse parti di un'opera.

Francesco Diaco
Di cenere e di luce
La poesia italiana degli ultimi cinquant’anni
Il libro si occupa della poesia italiana tra 1975 e 2025, ossia in un mezzo secolo perfettamente diviso tra due millenni. L’ampio capitolo iniziale ambisce a dar conto, con un’esposizione chiara e sistematica, delle questioni centrali nell’attuale dibattito critico, coniugando inquadramenti storico-culturali, percorsi tematici e riflessioni teoriche, nell’intento di fornire al lettore (non necessariamente specialista) una guida introduttiva utile per orientarsi nell’“astro esploso” del panorama poetico recente. Dopo aver analizzato fenomeni di grande rilievo, come le diverse rappresentazioni del corpo e degli oggetti, dello spazio e del tempo, della natura e della storia, vengono quindi affrontati snodi decisivi, quali la messa in discussione o la tenuta dei fondamenti del genere (a partire dal soggetto lirico) e della sua tradizione, le molteplici trasformazioni del suo statuto, delle sue forme e delle dinamiche sociologiche che lo caratterizzano. I successivi cinque capitoli – a cui si aggiunge un’intervista in appendice – approfondiscono l’opera di alcuni tra i più importanti autori del canone postremo, differenti per generazione (da Sereni a Magrelli) e poetica, ma tutti, in vario modo, definibili come “classici contemporanei”. La pluralità dei metodi adottati e degli elementi presi in esame – i tratti stilistici, i rapporti intertestuali, i motivi più ricorrenti nei corpora, la struttura dei macrotesti, la genesi e la ricezione delle raccolte, la comparazione con altri saperi (in primis filosofia e psicanalisi), altre arti e letterature – è indispensabile per indagare un ambito così complesso e mutevole, un campo problematico e di nicchia, per certi versi segnato dalle tonalità occidue del declino, ma capace di opporre al funebre grigiore della cenere i bagliori della bellezza, una dinamica vitalità e un’estrema ricchezza di voci, sperimentalismi, ibridazioni.

Maria Antonietta Terzoli
Dante autore e maestro
Suggestioni e ipotesi per Commedia, Trionfi, Decameron
Con la memorabile invocazione rivolta a Virgilio in apertura della Commedia – «Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore» – Dante codifica in maniera emblematica un paradigma storiografico che riconosce nella tradizione il punto di partenza e l’avvio della scrittura. E con il poema che si accinge a scrivere si pone egli stesso come autore e maestro per le generazioni successive. Il volume propone saggi dedicati alla Commedia e saggi dedicati a scrittori e artisti per i quali Dante è maestro imprescindibile: modello implicito o esplicito di opere che con la Commedia costantemente dialogano. Quali opere d’arte possono aver ispirato quelle del Purgatorio? Si può riconoscere nei bassorilievi della superbia un’aporia programmatica, che impone un esercizio di umiltà cognitiva? Nelle prime parole rivolte a Dante da Beatrice sono nascosti la firma e il titolo del poema? La seconda parte del libro riflette su come il magistero dantesco abbia influenzato Petrarca e Boccaccio, cercando di scoprire l’identità della misteriosa guida dei Trionfi e riconoscendo suggestioni della Commedia nella sesta giornata del Decameron.

A cura di Angela Ferrari, Letizia Lala, Filippo Pecorari
Dal centro alla periferia dell'italiano istituzionale svizzero
I quindici saggi raccolti nel volume chiudono, e nel contempo aprono verso nuove prospettive, le ricerche che per quattro anni hanno fatto capo al progetto nazionale svizzero "L'italiano istituzionale svizzero. Analisi, valutazioni, prospettive", diretto da Angela Ferrari presso l'Università di Basilea.
Il titolo del libro - Dal centro alla periferia - da una parte rispecchia il cammino delle ricerche condotte nell'ambito del progetto, che hanno allargato la loro visuale dalla prammatica alla pragmatica, dalla traduzione umana alla traduzione assistita e automatica, dagli aspetti qualitativi agli aspetti quantitativi; dall'altra parte consente di restituire alcune gerarchie che caratterizzano gli usi dell'italiano istituzionale svizzero e che sono legate alle dimensioni diamesica, diafasica, diatopica; dalle varietà scritte alle varietà parlate; dal linguaggio normativo al linguaggio giudiziario, dalla lingua della Confederazione e del Cantone Ticino alla lingua del Cantone dei Grigioni.
I saggi sono firmati dai curatori del volume - Angela Ferrari, Letizia Lala, Filippo Pecorari e da un gruppo di giovani ricercatori che hanno collaborato attivamente al progetto. A loro si aggiunge Jean-Luc Egger, capo-sostituto della Divisione italiana della Cancelleria federale svizzera, a cui si deve anche la Premessa del volume, che sottolinea l'importanza delle analisi proposte anche in prospettive applicata.

I profili dell'Italiano istituzionale tra Svizzera e Italia
Atti del convegno internazionale dedicato a Bice Mortara Garavelli
Una felice configurazione astrale ha fatto coincidere diversi eventi indipendenti
la cui convergenza ha reso possibile il convegno del quale si riuniscono
qui gli atti. Da un lato, la ventesima edizione dei seminari di traduzione e
revisione organizzati dalla Divisione italiana dei Servizi linguistici centrali
della Cancelleria federale, un appuntamento ormai tradizionale e affermato
nel panorama dell’offerta formativa destinata a redattori, traduttori e giurilinguisti
dell’Amministrazione federale svizzera. D’altro lato, la maturazione
dei principali risultati del progetto di ricerca quadriennale L’italiano istituzionale
svizzero: analisi, valutazioni, prospettive diretto da Angela Ferrari presso
l’Istituto di italianistica dell’Università di Basilea, un’iniziativa scientifica
senza precedenti in Svizzera per orizzonte tematico e profondità di analisi.
Inoltre, l’attenzione viepiù regolare e intensa da parte dell’Accademia della
Crusca per gli usi istituzionali e giuridici della lingua italiana, un interesse
coltivato già da tempo grazie ai lavori illuminanti di accademici di spicco
ma andato negli ultimi anni concretizzandosi sempre più frequentemente
anche in incontri, corsi e pubblicazioni incentrati proprio su questa varietà
linguistica d’importanza cruciale per la vita civile. Vi si è aggiunta l’ospitalità
generosa dei responsabili dell’Accademia unita alla cornice unica della Villa
Medicea di Castello con il suo particolare genius loci propizio alle riflessioni
linguistiche d’ampio respiro. Ma, infine, tale costellazione favorevole di circostanze
poco avrebbe sortito senza la partecipazione intelligente e la disponibilità
di tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’incontro,
ossia relatori, pubblico, seminaristi, accademici, artisti, tecnici, intendenze e
le istituzioni patrocinanti; a tutti rivolgiamo i nostri sinceri ringraziamenti.
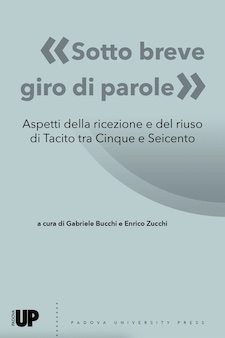
Gabriele Bucchi, Enrico Zucchi
«Sotto breve giro di parole» - Aspetti della ricezione e del riuso di Tacito tra Cinque e Seicento
“Ritenere sotto breve giro di parole concetti grandi e spiritosi e sentenze gravissime che talora danno diletto e maraviglia insieme”. Con queste parole un traduttore del primo Seicento, Girolamo Canini, esprimeva un’idea del “profitto” che il grande pubblico poteva ricavare dalla lettura di Tacito. Questo volume raccoglie tredici contributi dedicati ad altrettanti casi di ricezione dello storico romano nell’età moderna (dalla fine del Cinquecento alla fine del Seicento), concentrandosi in particolare su modalità e scopi della citazione e rifunzionalizzazione dell’autore degli Annales all’interno di contesti politici e geografici diversi (Italia, Spagna, Olanda). Attraverso lo studio di tipologie testuali e generi letterari quali la trattatistica politico-morale, le raccolte di aforismi, la satira, le lezioni accademiche, ma anche le annotazioni personali destinate a uso privato, i saggi qui raccolti delineano il progressivo trasformarsi del tacitismo da oggetto di indagine prevalentemente storico-filologica in un fenomeno editoriale e sociale di notevole portata e di indubbio successo.
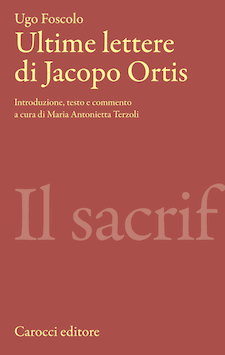
Maria Antonietta Terzoli
Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis
quarta ristampa
Romanzo epistolare tra i più significativi in area italiana, le Ultime lettere di Jacopo Ortis ebbero straordinaria fortuna di pubblico a inizio Ottocento, e notevole influenza su scrittori come Manzoni e Leopardi, nonché sulla narrativa epistolare successiva. Libro di forte cifra autobiografica e di scottante attualità politica, il romanzo ebbe una storia editoriale complessa - segnata anche dalla censura - tra il 1798 e il 1817. Si propone qui la stampa zurighese del 1816, pubblicata dal Foscolo durante l'esilio svizzero, che costituisce l'edizione più completa, arricchita da un originale apparato iconografico e dalla splendida Notizia bibliografica. Il commento, anzitutto esplicativo della lettera del testo, registra l'intertestualità foscoliana più significativa, senza tuttavia segnalare tutti i loci paralleli. I rinvii alle molteplici fonti propongono una radiografia dei debiti foscoliani e suggeriscono una linea interpretativa articolata, facendo posto anche alla competenza scritturale dell'autore e alla sua memoria dei testi sacri.

Filippo Pecorari (éd.)
Le istituzioni pubbliche sui social media: lingua e comunicazione
Bulletin VALS-ASLA, numero 118
Il volume, costituito da sette contributi, presenta al suo interno numerose sfaccettature e vuole essere rappresentativo delle principali linee attuali di ricerca linguistica sulla comunicazione istituzionale via social media. Gli articoli riflettono anzitutto la diversità delle piattaforme usate al giorno d'oggi dalle istituzioni per comunicare con la cittadinanza: trovano spazio nel volume riflessioni incentrate su Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube. Anche le prospettive di analisi e le metodologie adottate negli articoli sono all'insegna della varietà. Si va da approcci più tradizionali, fondati sull'analisi linguistica della qualità dei testi amministrativi nei suoi principali livelli (morfologia, morfosintassi, sintassi, lessico, testualità), ad approcci basati sull'analisi del discorso, sull'analisi socio-pragmalinguistica, sulla traduttologia applicata, sulla semiotica multimodale. I metodi quantitativi e qualitativi, negli studi raccolti, trovano un bilanciamento e, a tratti, una felice combinazione. I soggetti istituzionali che comunicano via social media sono numerosi, e anche sotto questo aspetto il volume rappresenta diverse anime: gli articoli affrontano la comunicazione di istituzioni pubbliche centrali (Governi, Ministeri), di istituzioni pubbliche periferiche (Università, istituti di promozione culturale, enti di promozione turistica), di politici provvisti di un ruolo istituzionale. Sono infine molteplici anche i contesti politico-istituzionali esaminati nei saggi del numero tematico: l'Italia (e l'italiano) è al centro della trattazione, ma trovano spazio anche la Svizzera (con particolare attenzione all'italiano lingua ufficiale) e la Francia (con particolare attenzione alla comunicazione rivolta verso l'Italia).

Francesco Diaco
L’ingratitudine dell’ospite. Fortini e la lirica moderna
https://books.fupress.it/catalogue/lingratitudine-dellospite/15079
Davanti alla poesia contemporanea, Fortini avverte «la forza di due passioni contrarie, quella verso la partecipazione e quella verso il distacco, da cui derivano tanto la presenza quanto l’ingratitudine dell’ospite». Anche come studioso, perciò, si pone sulle soglie e le frontiere, interessandosi al mainstream lirico otto-novecentesco e insieme guardando al di fuori di esso, verso un’estetica preromantica o verso l’avvenire. Ciò che unisce i vari ambiti della sua attività critica qui indagati – comparatistica e francesistica (Baudelaire, i simbolisti, il Surrealismo), metricologia e teoria letteraria, italianistica (Saba, Noventa) e traduttologia – è la postura assunta di fronte a una modernità che non viene rinnegata in toto, bensì attraversata dialetticamente, in vista di una società capace di coniugare libertà individuali e destini generali.
Quick Links
